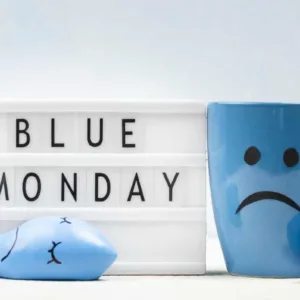Professore Associato del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario Aziendale dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano
- 1. Scenario e trend: i virus influenzali
- 2. Co-circolazione e diagnosi: come orientarsi tra i virus
- 3. L’impatto dei virus influenzali: cfr. età
- 4. Automedicazione e uso responsabile dei farmaci da banco
- 5. Alfabetizzazione sanitaria e comunicazione: il ruolo di Assosalute
- 6. Ruolo della vaccinazione:
- 7. Il futuro della prevenzione: cosa aspettarsi e su cosa puntare
- 8. Un messaggio ai cittadini
1. Scenario e trend: i virus influenzali
Dopo i numeri da record della stagione 2023-2024, anche la stagione 2024-2025 è stata caratterizzata da una elevatissima incidenza di sindromi simil-influenzali e per la pressione sui servizi sanitari, con un impatto particolarmente forte su bambini e anziani. Quali sono, secondo lei, le principali lezioni che possiamo trarre da quanto avvenuto nelle ultime due stagioni? Inoltre, quali sono le prospettive per l’autunno-inverno 2025-2026, che stagione invernale ci aspetta?
Una delle principali lezioni che possiamo trarre riguarda il ruolo dei contatti sociali: il ritorno alla normalità dopo il periodo della pandemia ha favorito una maggiore interazione tra le persone, aumentando la circolazione dei virus respiratori. Anche i fattori meteorologici hanno avuto e avranno un ruolo importante: i periodi di freddo intenso sembrano facilitare la diffusione dell’influenza, mentre in condizioni più variabili, con gli sbalzi termici, tendono a circolare virus “cugini”, meno gravi ma comunque capaci di generare epidemie significative.
Un altro aspetto da considerare è la pressione sui servizi sanitari. La presenza precoce di infezioni meno gravi può indebolire le difese immunitarie della popolazione, favorendo poi l’arrivo di una stagione influenzale più intensa, e quindi, aumentando il rischio di una pressione maggiore sui servizi sanitari come i Pronto Soccorso o gli ambulatori di medici di famiglia e pediatri.
Questo schema si ripete ogni anno: una “pre-stagione” con virus meno impattanti da un punto di vista clinico-sanitario prepara il terreno per la comparsa dell’influenza “vera e propria”, generalmente predominante al centro dell’inverno.
Guardando all’autunno-inverno 2025-2026, i segnali che arrivano dall’emisfero Sud, in particolare dall’Australia, indicano già un aumento dei casi. Anche in Italia ci si aspetta una stagione con elevata incidenza, con circa 16 milioni di persone potenzialmente coinvolte. Per essere più cauti, facendo tesoro dell’esperienza australiana si può stimare che verranno coinvolto tra il 15 e il 25% della popolazione. È probabile che i primi casi compaiano già a metà ottobre, con un progressivo aumento verso il picco invernale.
2. Co-circolazione e diagnosi: come orientarsi tra i virus
Quest’anno si parla molto di co-circolazione di diversi virus respiratori (influenza, virus respiratorio sinciziale – RSV, SARS-CoV-2, rhinovirus). È possibile per i cittadini, riuscire a distinguere tra questi virus o servono necessariamente tamponi/approfondimenti diagnostici? Se ci sono delle differenze, quali sono? E quali sono i sintomi a cui prestare maggiore attenzione?
Quest’anno ci aspettiamo la co-circolazione di diversi virus respiratori, tra cui virus influenzali (ceppi A H1N1 e B Victoria), virus respiratorio sinciziale (RSV), SARS-CoV-2 e rhinovirus. Dato che inAustralia, si osserva già la circolazione simultanea di questi virus, è probabile che la situazione si ripeta anche in Italia. In particolare, il ceppo B Victoria, meno diffuso negli anni scorsi e verso cui la copertura vaccinale è minore, potrebbe determinare un aumento dei contagi, anche se entrambi i ceppi influenzali sono inclusi nel vaccino stagionale.
Dal punto di vista clinico, distinguere tra questi virus basandosi solo sui sintomi è spesso difficile per i cittadini. Tuttavia, esistono alcune caratteristiche peculiari:
- L’influenza vera e propria si manifesta con un inizio brusco della febbre, almeno un sintomo respiratorio (come tosse o mal di gola) e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, malessere generale o senso di “bastonatura”. Questi sintomi sono particolarmente evidenti negli adulti, mentre nei bambini piccoli e negli anziani la febbre può essere meno intensa o, addirittura, assente.
- Virus respiratorio sinciziale, metapneumovirus e altri virus respiratori: i sintomi possono essere simili a quelli influenzali, ma di solito meno marcati e più graduali. Possono presentarsi congestione nasale, tosse lieve o sintomi gastrointestinali.
- Rhinovirus e altri virus minori: spesso causano sintomi più lievi e localizzati, come naso chiuso o lieve malessere.
- SARS-CoV-2 (Covid-19): può presentarsi con sintomi molto variabili, che possono includere quelli respiratori, sistemici e gastrointestinali. L’unico modo sicuro per confermare un’infezione da Covid-19 è il tampone, soprattutto per soggetti fragili o con comorbidità, poiché alcune persone possono essere asintomatiche ma comunque contagiose.
È importante sottolineare che, sebbene le varianti influenzali previste per la prossima stagione e quelle di SARS-CoV-2 siano generalmente meno patogene rispetto al passato, continuano a rappresentare un rischio significativo per anziani e persone con patologie croniche, come dimostrano i recenti decessi verificatisi anche in Italia.
3. L’impatto dei virus influenzali: cfr. età
Alla luce della presenza di virus diversi – dal virus respiratorio sinciziale (RSV) al Covid-19 – quanto è importante distinguere l’impatto per fascia di età, in particolare tra neonati, bambini piccoli, adulti e anziani? E come deve cambiare il comportamento di cura/la soglia di attenzione? Andare al pronto soccorso? Sì o no? E quando può essere necessario?
Distinguere l’impatto dei virus respiratori in base all’età è fondamentale, perché neonati, bambini piccoli, adulti e anziani reagiscono in modo molto diverso alle infezioni.
Nei neonati e nei bambini entro il primo anno di vita, ad esempio, il virus respiratorio sinciziale (RSV) può provocare bronchiolite e gravi difficoltà respiratorie. Per proteggerli, oggi esistono anticorpi monoclonali che, se somministrati nei primi mesi di vita, offrono una protezione temporanea durante il periodo invernale, quando l’RSV e l’influenza circolano di più. Questi anticorpi non sono un vaccino, ma rappresentano una misura importante per ridurre il rischio di complicanze nei soggetti più fragili.
Negli adulti e negli anziani, lo stesso virus tende a comportarsi come una normale influenza, ma non bisogna sottovalutare la possibilità di complicanze batteriche. Se la febbre o i sintomi respiratori persistono oltre tre o quattro giorni, può insorgere una sovrainfezione, tipicamente da pneumococco o streptococco pneumoniae che, in inverno, trova terreno più favorevole grazie alla sinergia con i virus influenzali. Negli anziani, è quindi particolarmente importante osservare segnali come un aumento della frequenza cardiaca o confusione mentale, poiché possono indicare condizioni più gravi.
Il Covid-19, poi, può manifestarsi in modi molto variabili, a volte con sintomi lievi simili a un semplice raffreddore, ma nelle persone fragili può avere conseguenze severe. Per questo è consigliabile fare un tampone in presenza di sintomi respiratori e mantenere comportamenti protettivi, come l’uso della mascherina, soprattutto quando si entra in contatto con anziani o persone vulnerabili.
Per quanto riguarda la soglia di attenzione e la necessità di recarsi al pronto soccorso, non è necessario andare in ospedale per sintomi lievi o iniziali. Diventa invece importante rivolgersi a un medico o a strutture sanitarie in presenza di difficoltà respiratoria significativa, febbre che persiste oltre alcuni giorni, peggioramento delle condizioni generali, confusione mentale negli anziani o qualsiasi segnale di complicanza nei neonati e nei bambini piccoli.
In generale, quindi, il comportamento di cura deve essere modulato in base all’età e alla vulnerabilità del paziente. Nei neonati e nei bambini piccoli l’attenzione deve essere massima per prevenire problemi respiratori seri, mentre negli anziani è cruciale monitorare l’evoluzione dei sintomi per riconoscere tempestivamente eventuali complicanze. L’automedicazione e quindi l’utilizzo di farmaci da banco per la gestione dei sintomi deve essere sempre responsabile, perché i sintomi sono uno strumento utile per capire se la malattia procede verso il miglioramento o se invece richiede interventi più mirati.
4. Automedicazione e uso responsabile dei farmaci da banco
Durante le ondate influenzali, il ricorso ai farmaci da banco è spesso la prima risposta dei cittadini ai sintomi tipici quali febbre, malesseri respiratori, mal di testa, stanchezza. Quali sono i benefici e i potenziali rischi di questo approccio e quali consigli si sente di dare per un uso davvero responsabile, soprattutto per le categorie più vulnerabili?
Durante le ondate influenzali, il ricorso ai farmaci da banco rappresenta spesso la prima risposta ai sintomi comuni come febbre, malessere respiratorio, mal di testa e stanchezza. L’automedicazione, se effettuata in modo responsabile e proporzionata all’intensità dei sintomi, è una scelta terapeutica adeguata perché può offrire diversi benefici. Innanzitutto, permette di alleviare i disturbi e migliorare il benessere generale, modulando, al contempo, la risposta immunitaria, riducendo il rischio di complicanze. Questo aspetto è particolarmente rilevante negli anziani, nei quali una reazione immunitaria eccessiva può contribuire a complicanze più gravi, come la polmonite interstiziale tipica delle infezioni virali. Si tratta di un approccio è consolidato per molte infezioni respiratorie virali, incluse quelle causate da metapneumovirus, adenovirus, parainfluenza e coronavirus diversi dal Covid-19.
I farmaci da banco, come tutti i medicinali, possono avere degli effetti avversi. Resta fondamentale usarli in modo appropriato e corretto seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo o quanto indicato dal medico o del pediatra. Questo significa, ad esempio, seguire le indicazioni date per quanto concerne tempi di somministrazione e dosaggi. In caso di infezioni virali l’uso dei farmaci da banco deve servire a contenere i sintomi e i disagi legati alla malattia senza azzerare completamente i sintomi per seguire l’evolversi della malattia
L’automedicazione responsabile si basa sull’uso ragionevole di farmaci come gli antinfiammatori, che non solo alleviano i sintomi, ma aiutano anche a modulare la risposta immunitaria,
Per le categorie più vulnerabili, come gli anziani o i soggetti fragili, è importante integrare l’automedicazione con la valutazione medica tempestiva. In caso di sospetto Covid-19, un tampone rapido può guidare l’eventuale prescrizione di farmaci specifici, come il Paxlovid, che deve essere somministrato sotto controllo medico e per un periodo definito di cinque giorni. Tuttavia, non tutti gli anziani possono assumere questo trattamento a causa di possibili interazioni con altri farmaci.
5. Alfabetizzazione sanitaria e comunicazione: il ruolo di Assosalute
La disinformazione e le fake news continuano a rappresentare un ostacolo alla prevenzione e alla gestione corretta delle infezioni respiratorie. Quanto è importante oggi l’alfabetizzazione sanitaria – a partire proprio dalle scelte individuali e da un uso corretto dei farmaci di automedicazione – e come valuta il ruolo delle associazioni di settore nella promozione di una cultura della salute più consapevole?
Per me, alfabetizzazione sanitaria e informazioni corrette non sono solo utili: sono indispensabili. Solo così possiamo aiutare le persone a gestire la propria salute in modo consapevole e Assosalute che promuove il progetto editoriale Semplicemente Salute, insieme alle associazioni di settore rimane un alleato prezioso in questo percorso.
Oggi disinformazione e fake news sono un vero problema per la prevenzione e la gestione delle infezioni respiratorie. Per questo credo che l’alfabetizzazione sanitaria sia fondamentale: ognuno di noi deve saper fare scelte consapevoli, anche quando si tratta di usare farmaci da banco. Bisogna capire, per esempio, quando è meglio usare un principio attivo singolo o un farmaco combinato in base ai sintomi. All’inizio, se ho febbre alta, tosse e naso chiuso, scelgo un farmaco specifico; poi, quando magari resta solo un po’ di tosse, passo a qualcosa di più mirato.
In tutto questo, Assosalute fa un lavoro prezioso. Da anni cerca di dare strumenti chiari e informazioni affidabili ai cittadini, così ognuno può prendersi cura della propria salute con responsabilità. Contribuisce a diffondere conoscenze corrette e a contrastare la disinformazione.
6. Ruolo della vaccinazione:
Professore, ci aiuti a fare chiarezza sulla vaccinazione antiinfluenzale. Oltre agli over 60 a chi è consigliata? Se si fa il vaccino si evitano completamente i sintomi respiratori? Quali vaccinazioni sarà possibile effettuare quest’anno, oltre a quella “classica” contro l’influenza (anche quella contro il Covid-19? ad esempio)? Per il RVS, come comportarsi?
La vaccinazione antiinfluenzale rappresenta un’opportunità per tutti, ma diventa particolarmente importante per le persone più fragili, come gli anziani o chi presenta patologie croniche. Non è destinata esclusivamente agli over 60: anche adulti con fattori di rischio e alcune categorie professionali possono trarne beneficio.
È importante sottolineare che la vaccinazione non garantisce l’assenza completa dei sintomi respiratori: l’efficacia può variare di anno in anno a seconda della corrispondenza tra ceppi vaccinali e virus circolanti. Tuttavia, il vaccino riduce l’intensità della malattia e il rischio di complicanze gravi. Inoltre, alcune infezioni respiratorie possono essere causate da virus diversi dall’influenza (ad esempio, il virus respiratorio sinciziale, RSV), quindi la comparsa di sintomi simil-influenzali non significa che il vaccino sia inefficace.
Per la stagione in corso, oltre al vaccino antiinfluenzale “classico”, è possibile ricevere anche la vaccinazione contro il Covid-19. Le due vaccinazioni possono essere somministrate nello stesso appuntamento, poiché si effettuano in due punti diversi del corpo. Questo rappresenta un’occasione per valutare anche altre vaccinazioni raccomandate per gli anziani o soggetti a rischio, come:
- Vaccino antipneumococcico (utile per prevenire polmoniti e altre complicanze respiratorie; generalmente basta una dose nella vita salvo casi particolari)
- Vaccino contro l’herpes zoster
- Richiami per tetano e altre vaccinazioni previste nel calendario vaccinale.
In pratica, un singolo incontro può essere sfruttato per pianificare o effettuare più vaccinazioni, massimizzando la protezione della persona fragile.
Per quanto riguarda il virus respiratorio sinciziale (RSV), al momento non è ancora incluso nella pianificazione vaccinale di routine, ma sono già disponibili vaccini e strategie per specifiche categorie:
- Vaccinazione dell’anziano o del soggetto a rischio;
- Vaccinazione della mamma nell’ultimo trimestre di gravidanza per trasmettere anticorpi al neonato e proteggerlo nei primi mesi di vita;
- Somministrazione di anticorpi monoclonali al neonato, come alternativa alla vaccinazione materna.
Per i bambini piccoli (intorno a 1–1,5 anni), che sono particolarmente vulnerabili alle infezioni respiratorie come la bronchiolite, la vaccinazione RSV potrebbe rappresentare un’opzione futura, ma al momento non è ancora disponibile su larga scala.
7. Il futuro della prevenzione: cosa aspettarsi e su cosa puntare
Guardando al futuro, quali sono, secondo lei, le priorità su cui cittadini, istituzioni e operatori sanitari dovrebbero concentrarsi per affrontare al meglio le prossime stagioni influenzali e respiratorie? Può indicarci tre azioni concrete che potrebbero fare la differenza?
Guardando alle prossime stagioni influenzali e respiratorie, credo che ci siano tre ambiti su cui cittadini, istituzioni e operatori sanitari dovrebbero concentrarsi con azioni concrete e coordinate.
1. Ricostruire fiducia e adesione alle vaccinazioni.
L’esperienza della pandemia ha lasciato un clima di diffidenza verso i vaccini: un atteggiamento inizialmente legato al Covid-19, che oggi rischia di estendersi anche ad altre vaccinazioni fondamentali, come dimostra la recrudescenza del morbillo. È essenziale superare queste resistenze, perché le malattie infettive respiratorie — il Covid in primis, così mutevole e “camaleontico” — non vanno sottovalutate: i loro effetti negativi possono essere molto gravi, soprattutto per anziani e fragili, e comportano anche pesanti costi sociali.
2. Promuovere un uso corretto dell’automedicazione.
Un secondo punto cruciale riguarda l’educazione dei cittadini a gestire in modo responsabile i sintomi lievi, ricorrendo ai farmaci da banco quando appropriato e senza abusare degli antibiotici. Troppo spesso, infatti, si ricorre ancora a cure inadeguate, come l’uso di antibiotici rimasti in casa, nonostante la maggior parte delle infezioni respiratorie all’esordio sia di origine virale e non richieda questo tipo di trattamento. Un’automedicazione consapevole, oltre a migliorare la gestione dei disturbidi lieve entità, riduce la pressione sul sistema sanitario e contribuisce a limitare l’antibiotico-resistenza.
3. Sfruttare tutte le occasioni per vaccinare i pazienti.
Infine, le istituzioni e gli operatori sanitari devono organizzarsi per cogliere ogni opportunità di vaccinazione, anche al di fuori delle campagne stagionali tradizionali. Un esempio efficace è quello di somministrare il vaccino pneumococcico a un paziente anziano o fragile durante la degenza ospedaliera, prima della dimissione, indipendentemente dal periodo dell’anno. Questa strategia, che amplia le possibilità oltre la sola offerta attiva di medici di famiglia e ASL, permette di incrementare la copertura vaccinale e proteggere meglio chi è più a rischio.
8. Un messaggio ai cittadini
In chiusura, quale messaggio si sente di lanciare ai cittadini italiani per la prossima stagione, in termini di prevenzione, gestione dei sintomi e uso consapevole delle risorse sanitarie?
Alla vigilia della prossima stagione influenzale e respiratoria, il messaggio che vorrei lanciare ai cittadini italiani è quello della responsabilità personale nella prevenzione e nella gestione della propria salute e dui quella di chi gli è caro. Un esempio concreto è l’automedicazione consapevole, che non significa agire in modo superficiale o sostituirsi al medico, ma sviluppare quella che viene definita “medical literacy”: la capacità di informarsi correttamente, comprendere i sintomi e adottare comportamenti appropriati
Essere proattivi nella cura di sé vuol dire saper distinguere quando è sufficiente ricorrere a farmaci da banco per alleviare disturbi lievi e quando, invece, è necessario rivolgersi al medico. Questo atteggiamento, che parte dall’automedicazione responsabile, e da un uso corretto dei farmaci da banco va inserito in un quadro più ampio di consapevolezza sanitaria, in cui ogni cittadino contribuisce, con le proprie scelte, non solo al proprio benessere ma anche a un uso più sostenibile delle risorse del sistema sanitario.

Attraverso consigli pratici e informazioni chiare, ci dedichiamo a educare e guidare verso scelte di vita quotidiana consapevoli, promuovendo un benessere semplice e duraturo.